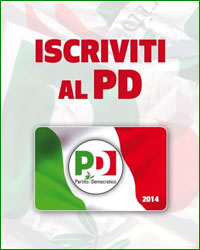Da il post.it
I partiti al governo – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – ci sono arrivati con la promessa di ridurre le tasse, e dicono spesso che lo stanno facendo con successo. Ma non è proprio così. Dal 2023 infatti il carico fiscale è notevolmente aumentato, e contribuirà a tenerlo alto anche la legge di bilancio che il governo ha appena presentato in parlamento, che la dovrà discutere e approvare entro la fine dell’anno. Prevede per quest’anno una pressione fiscale ai massimi degli ultimi dieci anni. La prospettiva non migliora nel prossimo biennio.
La pressione fiscale alta non è frutto soltanto dell’azione di questo governo: in Italia è alta da sempre, serve tra le altre cose a finanziare uno stato sociale tra i più generosi d’Europa per pensioni e sanità. Non è un bene o un male di per sé, è semplicemente una caratteristica come un’altra del sistema economico (anche se qualcosa si potrebbe dire sulla qualità della spesa pubblica italiana). Guardando il suo andamento nel tempo, però, si capisce cosa hanno deciso al riguardo i diversi governi.
La pressione fiscale si misura con la somma di determinate imposte: quelle indirette (tra cui l’IVA sui consumi) e dirette (come l’IRPEF sui redditi), le imposte in conto capitale (come quelle sulla successione), i contributi sociali (come quelli che finanziano le pensioni e i congedi parentali). Dalla pressione fiscale sono escluse alcune voci residuali, come le cosiddette “altre entrate” e le “entrate in conto capitale non tributarie”: sommandole si ottiene il valore delle entrate totali, cioè quanto incassa davvero lo Stato dalle tasse. In poche parole: la pressione fiscale è l’indicatore da guardare per vedere l’andamento delle tasse su cui può davvero agire il governo (per esempio abbassando l’IRPEF o l’IVA, e via così); le entrate totali danno un quadro più realistico considerando tutto quanto, anche cosa è fuori dal potere del governo.
Le entrate totali sono dunque sempre più alte della pressione fiscale, ma i due valori hanno sostanzialmente lo stesso andamento. Si usa metterli in rapporto al PIL, cioè alla dimensione dell’economia.
Il governo di Giorgia Meloni è entrato in carica a ottobre del 2022 e, come si vede dal grafico, da allora le entrate totali e la pressione fiscale sono aumentate rispettivamente di 1 punto e di 1,3 punti percentuali di PIL: ai valori di oggi significa che sono più alte di circa 28 e 22 miliardi di euro. Nel secondo trimestre di quest’anno, l’ultimo per cui sono disponibili i dati, i due indicatori sono arrivati ai massimi degli ultimi dieci anni, al 42,8 e al 47,6 per cento. Sono valori vicino a quelli raggiunti durante il governo di Mario Monti, il governo nato per mettere a posto i conti pubblici in un momento di grande difficoltà economica, nel 2011, e diventato poi simbolo delle politiche di “austerità”.
Secondo le previsioni del governo di Meloni nel 2025 la pressione fiscale si chiuderà al 42,8 per cento del PIL, in aumento rispetto al 42,5 del 2024, e il valore più alto dal 2015. Nel 2026 il disegno di legge presentato prevede che rimarrà stabile al 42,8 per cento. Secondo i calcoli dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani la pressione fiscale aumenterà ancora al 42,9 per cento nel 2027, per poi scendere al 42,7 nel 2028. Un andamento simile lo avranno le entrate totali. Questo significa che quasi la metà di ciò che produce l’economia finisce allo Stato.
I dati comunque non vengono presentati in maniera trasparente dal governo, perché fa un uso piuttosto estensivo delle voci di bilancio residuali, che restano quindi fuori dall’indicatore della pressione fiscale e lo falsano. La cosa viene denunciata da molte istituzioni ed esperti dall’anno scorso, quando fu impossibile capire se le tasse sarebbero aumentate o meno quest’anno.
A prescindere dal metodo a questo punto però potreste chiedervi: ma com’è possibile che la pressione fiscale sia aumentata così tanto mentre il governo dice di ridurre le tasse? Perché da una parte i dati dicono che erano da dieci anni che in Italia non si pagava un ammontare di tasse così alto; dall’altra è vero che il governo ha fatto alcune cose per ridurle.
Partiamo dagli interventi del governo. Ci sono effettivamente alcuni aumenti delle imposte: rinnegando anni di battaglie, il governo ha aumentato le accise sui carburanti e prevede un altro aumento per il prossimo anno; ha rimodulato il sistema di bonus fiscali a svantaggio dei redditi più alti; e vuole imporre per l’anno prossimo alcune tasse a banche e assicurazioni.
Ma i provvedimenti fiscali più significativi sono state due riduzioni. Il governo ha reso innanzitutto permanente il cosiddetto “taglio del cuneo fiscale”, cioè uno sconto sulle tasse dei lavoratori dipendenti che era stato introdotto dal governo di Mario Draghi per compensare l’aumento del costo della vita. Il passaggio dal regime transitorio a quello permanente è stato comunque un pasticcio, e dall’inizio dell’anno lo sconto è diminuito per diverse categorie di lavoratori, che hanno visto ridursi lo stipendio netto mensile.
Il governo ha poi ridotto le aliquote IRPEF, cioè le percentuali che si applicano agli scaglioni di reddito delle persone fisiche per stabilire quante imposte sono dovute. Nel 2022 le aliquote erano 4 mentre ora sono 3, ed è stata ridotta di due punti percentuali quella per i redditi sotto i 28mila euro. Il disegno di legge di bilancio per l’anno prossimo prevede una riduzione ulteriore dell’aliquota del secondo scaglione, che per i redditi tra i 28 e i 50mila euro passerà dal 35 al 33 per cento.
Seppure i due interventi di riduzione delle imposte appena menzionati siano in teoria consistenti, non hanno avuto l’effetto di ridurre il carico fiscale complessivo. Anzi.
Da quando si è insediato il governo di Meloni paghiamo materialmente più tasse per colpa di un meccanismo chiamato fiscal drag, o drenaggio fiscale, che esiste nei sistemi fiscali progressivi quando c’è un’inflazione elevata, come l’aumento generale del livello dei prezzi che si è visto negli ultimi quattro anni. Il sistema italiano è per l’appunto progressivo: significa che più si guadagna e più si paga una quota più alta di tasse, per il principio costituzionale che chi ha un reddito più alto deve contribuire in misura maggiore al fabbisogno dello Stato.
Quando aumenta il costo della vita si innescano anche aumenti delle retribuzioni per tentare di tenere il passo dei prezzi. Non è un problema di per sé, anzi, gli stipendi devono aumentare per adeguarsi gradualmente a una vita più cara: da gennaio del 2021 a gennaio del 2025 i prezzi sono aumentati complessivamente del 16 per cento, mentre le retribuzioni di poco più dell’8 per cento, la metà, ma l’andamento è positivo.
Il problema c’è quando questi aumenti avvengono in un sistema fiscale progressivo che non si adegua al nuovo livello di redditi, o non si adegua abbastanza: gli aumenti di stipendio spesso portano a sforare la soglia entro cui si ha diritto a bonus o detrazioni, o quella dello scaglione successivo in cui si pagano aliquote più alte (solo per la parte di reddito che sfora). Il drenaggio fiscale è proprio questo: in caso di inflazione comporta un tradimento del principio dell’equità del sistema fiscale, perché porta a pagare più tasse senza aver avuto davvero un miglioramento della propria situazione economica. Non solo si pagano più imposte sul reddito, ma con l’aumento generale dei prezzi si paga anche più IVA (che viene calcolata in percentuale del prezzo dei prodotti).
Deriva da questo fenomeno l’aumento delle entrate e della pressione fiscale in questi anni di governo di Meloni, che è stato avvantaggiato da un eccezionale aumento delle entrate senza aver dovuto imporre evidenti – e impopolari – aumenti delle tasse. Anzi, con questi soldi è riuscito anche a introdurre e propagandare alcune riduzioni delle imposte, che però nella pratica non hanno compensato il drenaggio fiscale.
Una stima di lavoce.info indica in 17 miliardi di euro l’aumento delle imposte incassate dallo Stato nel solo 2024 a causa del drenaggio fiscale. Un’altra stima dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio dice che proprio i due grandi interventi fiscali spiegati qui sopra non solo non hanno provocato una compensazione del drenaggio fiscale, ma lo hanno peggiorato per circa 300 milioni di euro all’anno.
E dire che un tempo Meloni ci teneva molto alla pressione fiscale
È stata una scelta precisa del governo, che ha deciso di non “restituire” al sistema i proventi del drenaggio fiscale, per esempio adeguando in misura appropriata le soglie di accesso ai bonus o gli scaglioni dell’IRPEF. Con tutti questi soldi in più ha deciso invece di mettere a posto i conti pubblici. Secondo il governo la pressione fiscale sarebbe aumentata perché è aumentata la gente al lavoro, e quindi le persone che pagano le tasse. Lo hanno detto più volte Meloni e il suo ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ma non è vero, e sono stati smentiti categoricamente dagli economisti.